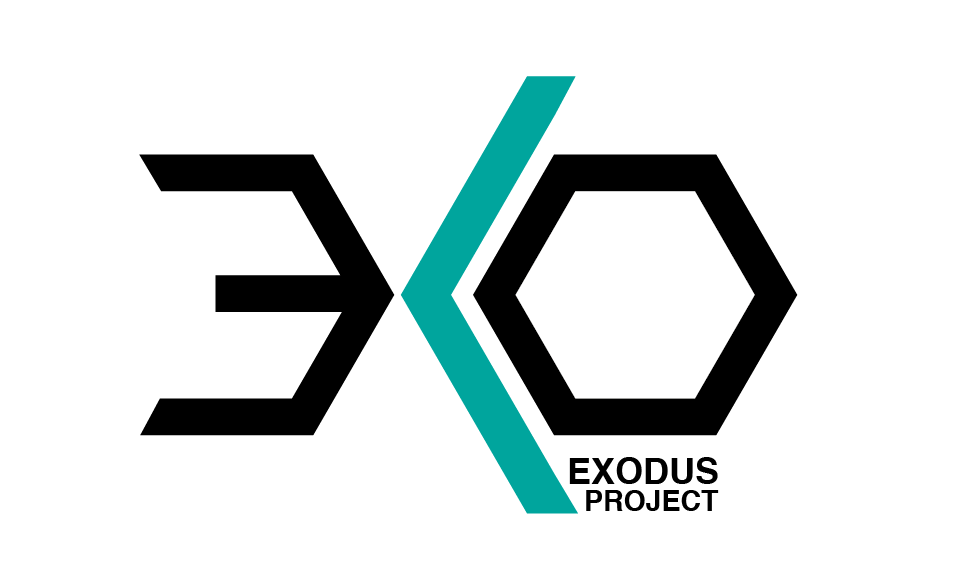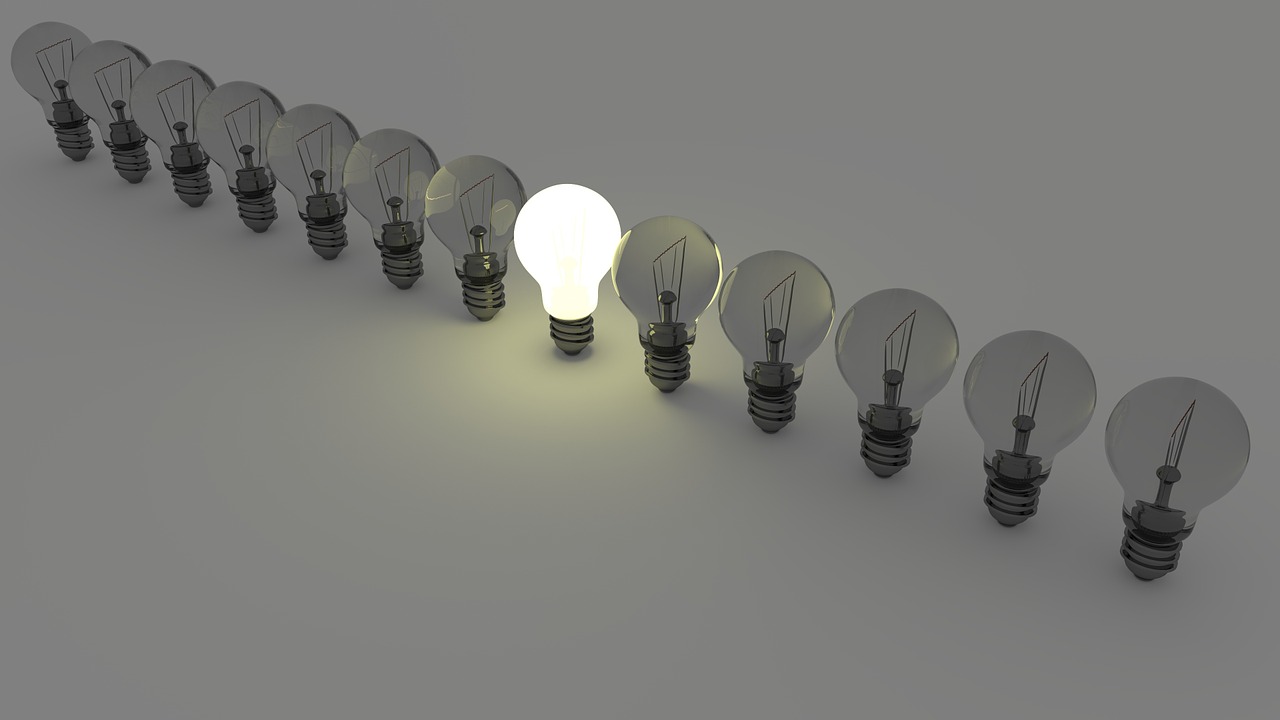A prescindere dagli schemi gerarchici e dagli archetipi culturali, fin dalle origini si è soliti trattare la differenza tra esseri umani come espressione di minor valore. Che sia di sesso, colore della pelle, etnia, religione o altro, la diseguaglianza è spesso fonte di inadeguatezza e si tenta di trasformarla secondo il gruppo di riferimento normativo.
Così, infatti, da secoli questa tendenza pone la capacità riproduttrice del corpo femminile come limite sociale delle donne. Non hanno avuto il diritto di partecipare alla vita cittadina per lungo tempo in quanto relegate agli aspetti della vita privata quali la cura della casa, l’alimentazione del marito, crescere i figli e quant’altro.
Il sol fatto di essere nati in un corpo femminile ti escludeva a prescindere da determinati contesti sociali: niente istruzione, niente lavoro, nessun guadagno e nessuna indipendenza.
Oltre il fatto che per anni è stato lo sguardo dell’uomo a definire la donna secondo i suoi canoni di purezza e sottomissione.
Chiaramente nel corso degli anni, soprattutto dopo la seconda metà del Novecento, nei paesi sviluppati – inclusa l’Italia – dopo lotte e discussioni, le disuguaglianze tra uomini e donne si sono ridotte, benchè questo accadeva a livello normativo e ha impiegato più tempo sul livello sociale. Ma poi, l’estremismo del femminismo ha causato casi di forte opposizione dove la troppa libertà ed emancipazione della donna la rendevano artefice dello stravolgimento della famiglia e del ribaltamento dei ruoli.
Insomma è come se per la figura della donna non ci sia una giusta via di mezzo anche perché le differenze tra i due sessi che troviamo oggi nelle democrazie occidentali sono dovute soprattutto al modo in cui è stata affrontata questa dualità dell’argomento:
differenza della donna e quindi diritti delle donne o uguaglianza agli uomini e quindi parità dei sessi?
Già le femministe della Rivoluzione Francese affrontano questa scissione di pensiero: Olympe de Gouges (1791) afferma che le donne siano “il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità”, mentre Mary Wollstonecraft rivendica diritti uguali per le donne come per gli uomini, nonostante la maternità sia una differenza irriducibile.
Quindi abbiamo chi sostiene la necessità di diritti del lavoro femminile per ridurre il sovraffaticamento e valorizzare il ruolo di madre e chi, dall’altro lato è contrario a delle riforme speciali perché nei diversi ambiti, ad esempio lavorativo, genera delle discriminazioni.
Nelle due posizioni è espresso il dilemma tra un’uguaglianza intesa come omogeneità all’uomo e quindi sacrificando il corpo e l’esperienza femminile, e una differenza che pone le donne uguali tra loro - perché potenziali madri - e di conseguenza diverse dagli uomini. L’affermazione della differenza genera l’emarginazione politica e sociale e l’affermazione dell’uguaglianza costringe le donne ad adattarsi ai ritmi e all’esperienza maschile.
L’alternativa potrebbe stare nel destrutturare gli interessi per la differenza:
si è uguali non perché identici ma perché le differenze di vario genere non creano diversità rispetto alla partecipazione in alcuni ambiti della vita sociale e privata.
L’uguaglianza non dovrebbe in alcun caso reprimere le differenze di genere, religione, colore della pelle, salute, istruzione e livello sociale.
Bisognerebbe creare uguaglianza in base a quattro criteri fondamentali nella vita dell’essere umano in generale: occupazione, famiglia, rappresentanza politica e decisioni sociali; creare per questi ambiti obiettivi e risorse che possano garantire l’uguaglianza per tutti.
Insomma, per la donna non dev’essere una scelta difficile o una questione di punto di vista ma il naturale svolgimento della sua vita che la rendono unica nel suo genere.
Abbracci contagiosi